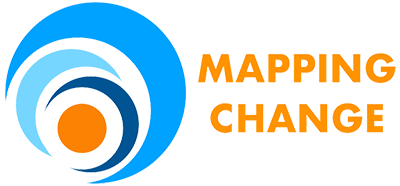Se volessimo ridurre all’osso lo scopo fondamentale del fundraising, potremmo dire che è quello di apportare – attraverso strategie e strumenti diversi – le risorse di breve, medio e lungo periodo, materiali e immateriali, di cui la nostra organizzazione ha bisogno.
In realtà questa definizione, pur nella sua semplicità e ragionevolezza, nasconde sotto testo un’ambiguità rischiosa:
Raccogliamo fondi per i bisogni della nostra organizzazione o per i bisogni e per i diritti delle persone per cui la nostra organizzazione esiste?
Questa differenza non è affatto banale e porta con sé un approccio radicalmente diverso al lavoro nel nostro settore, dove spesso, stretti fra la carenza di personale, problemi complessi da risolvere e finanziamenti insufficienti, finiamo per essere letteralmente triturati da una modalità costantemente emergenziale di lavorare: testa bassa e pedalare, senza più nemmeno preoccuparci di dove stiamo andando e di come ci stiamo andando.
Chi ha esperienza in organizzazioni non profit sa benissimo di che cosa sto parlando: si punta a finire i progetti al meglio nei tempi previsti, si rincorrono i bandi (anche quelli meno coerenti con la nostra mission), ci si improvvisa fundraiser all’occorrenza, si inseguono le mode del momento e via così.
Il risultato è che la nostra organizzazione riesce a sopravvivere grazie a un lavoro e a una passione immensi, ma galleggiando senza prospettiva e dovendo in qualche modo rinascere ogni giorno, quasi ripartendo da zero.
Se abbiamo la fortuna o l’occasione di guardare dall’alto questo enorme meccanismo frenetico, ci accorgeremmo immediatamente di quante energie vengano in realtà disperse a fronte di un impatto tutto sommato contenuto sulla vita delle persone per cui la nostra organizzazione esiste.
O, meglio ancora, ci renderemmo conto che non sappiamo neanche bene quale impatto di medio-lungo periodo stiamo avendo.
- Stiamo davvero cambiando le cose?
- Quanto?
- E quanto questo cambiamento dipende solamente e direttamente da noi?
- Finiti i progetti, che cosa resta?
Abbiamo delle rendicontazioni di progetto, dei feedback da alcuni stakeholder, se va bene un bilancio di missione o sociale a fine anno dove raccontiamo quante cose abbiamo fatto e quante persone abbiamo raggiunto, ma la dimensione, l’evidenza, la solidità del nostro lavoro ci sfugge.
Ci manca accountability, non siamo in grado di rendere conto del nostro specifico impatto.
È proprio qui che ci viene in soccorso la Teoria del Cambiamento, un approccio metodologico basato sul critical thinking che ci costringe a mettere in discussione l’intera mission e la capacita reale dell’organizzazione di generare cambiamento.
Come? Obbligandoci a monitorare e a valutare tutti i nostri interventi con opportuni indicatori e in modo sistematico, chiedendoci di crescere a livello di processi e di competenze, predisponendoci a individuare le criticità e le strade senza uscita del nostro procedere, spingendoci ad apprendere per migliorare in efficacia, efficienza, trasparenza e, infine, nell’impatto generato.
In sintesi, sviluppare una Teoria del Cambiamento, significa:
- Esplicitare e dimostrare non solo “se” un cambiamento avviene, ma soprattutto “perché” e “come”;
- Articolare un percorso che porti a tale cambiamento attraverso lo sviluppo di progetti, di strutture e di competenze organizzative specifici fondati su tali “perché” e “come” (e il reperimento delle relative risorse umane ed economiche);
- Elaborare e implementare un sistema di impact management & evaluation in grado di testare sia i presupposti sia la strategia sia gli strumenti messi in campo in itinere ed ex post.
Non è difficile comprendere come un investimento di questo tipo non solo sia indispensabile per focalizzare e potenziare le nostre strategie di progettazione e di funding, ma anche per tutte quelle attività di fundraising che hanno solo da guadagnare dalla ricchezza di fonti con le quali possiamo dimostrare quanto la nostra azione stia davvero lasciando il segno.